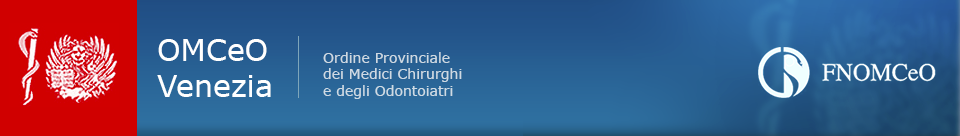- Home
- News
- Odontoiatri
Prendersi cura: il segreto per non morire in solitudine
Data di inserimento: Lunedì, 08/05/17 - Segreteria OMCeO Ve

Cambiare sguardo sulla morte, che non deve più essere un tabù, che non è l’opposto della vita, ma ne è un aspetto, un passaggio e come tale va affrontato, aprendosi al senso di mistero che la caratterizza. E ancora, per chi accompagna qualcuno verso le sue ultime ore: passare dall’essere, all’esserci. Non guardare la malattia pensando che non ci sia più nulla da fare, ma guardare la persona e capire quanto, invece, ancora si possa fare. E infine l’importanza, anche nei momenti finali della vita, delle relazioni, della socialità, delle cure palliative e della sinergia tra chi sta intorno al paziente morente: non solo i tanti professionisti sanitari, ma anche i caregivers e i familiari.
Sono solo alcune delle suggestioni arrivate, anche attraverso testimonianze dirette molto toccanti, sabato 6 maggio durante il convegno Quando si muore, si muore soli? organizzato all’Ateneo Veneto dall’OMCeO veneziano, attraverso la Fondazione Ars Medica, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Veneto. Una giornata di studi in cui medici, psicologi, infermieri, volontari si sono messi insieme per riflettere e cercare di dare qualche risposta possibile alla fondamentale domanda posta dal titolo della giornata.
I saluti delle autorità
Il convegno è stato aperto dai “padroni di casa”. Laura Dal Corso, segretario dell’Ordine veneto degli Psicologi, ha portato i saluti del suo presidente Alessandro De Carlo, assente per altri impegni istituzionali. «La sfida di oggi – ha spiegato – è quella di aprirsi al confronto. La forza di un evento come questo è quella di mettere insieme specifiche competenze, di lavorare insieme senza togliere spazio alla riflessione».
L’importanza di simili riunioni “multidisciplinari e pluri-intelletuali” è stata sottolineata anche da Giovanni Leoni, presidente dell’OMCeO veneziano, che ha portato i saluti di Maurizio Scassola, vicepresidente FNOMCeO, anche lui assente per altri impegni istituzionali a Torino, e poi ha aggiunto: «Il fine vita è una realtà per tutti noi, è un problema che ci tocca sia a livello personale che professionale. È un tema difficile da affrontare, la depressione è dietro l’angolo per tutti gli operatori, ma dobbiamo contrastarla con la razionalità».
Leoni ha anche letto un messaggio di buon lavoro arrivato dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia. «I temi del fine vita – scrive il capo della chiesa lagunare – sono oggi tanto dibattuti e delicati. Quando si parla di fine vita, non dobbiamo dimenticare che entra in gioco l’uomo, due persone concrete: il paziente e il medico. Siamo, quindi, chiamati a cercare e trovare il punto più alto di discernimento, saggezza ed equilibrio che allontanino il rischio sia dell’accanimento sia dell’abbandono terapeutico, quest’ultimo in forma di silente e nascosta eutanasia. Di fronte a scelte quasi sempre complesse e obiettivamente difficili, è essenziale coltivare attenzioni che siano anche pienamente umane. È necessaria una sorta di alleanza tra tutti i soggetti interessati per saper riconoscere potenzialità, limiti e fragilità umane e non lasciare mai soli pazienti e famiglie. La paura è umana e per vincerla bisogna avere accanto persone che aiutino e si prendano cura».
Il tema della sfida, lanciato in apertura, è stato ripreso poi da Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia. «La sfida importante di questo inedito convegno – ha detto – è quella, attraverso un’alleanza che coinvolge tutti, di non far più morire solo nessuno. La sfida non riguarda solo le professioni, ma anche le istituzioni, le aziende sanitarie, il legislatore, il mondo del volontariato. Con questa alleanza, che deve continuare a crescere, possiamo far sì che ci siano dignità, sicurezza e tranquillità per le persone anche nei loro ultimi istanti di vita. Da soli non si va da nessuna parte, insieme si va molto più distante».
«Affrontare questi temi – ha sottolineato, invece, Luigino Schiavon, presidente del Collegio IPASVI di Venezia – significa riconoscere che la morte ha diritto di cittadinanza nei nostri convegni. Quando in ospedale una persona sta morendo si mette un paravento, quasi a nascondere un evento sfavorevole, a stigmatizzarlo come cosa altra, diversa. Io credo che quel paravento vada tolto, soprattutto in termini culturali. La morte va affrontata come percorso».
In sala anche i rappresentanti delle aziende sanitarie locali, che hanno patrocinato l’iniziativa. «Questo convegno – ha detto Onofrio Lamanna, direttore sanitario dell’Ulss 3 Serenissima – affronta problemi sul tavolo da troppi anni. Secondo me si muore ancora troppo in ospedale: chi ci lavora sente come proprio il dovere di accompagnare alla morte il malato, ma non è il posto più idoneo per il fine vita».
«Un tema difficile – ha spiegato a sua volta Mauro Filippi, direttore dei servizi sociali dell’Ulss 4 Veneto Orientale – e di grande attualità. Da tempo ormai si cerca di allontanare la morte nel tempo e nei luoghi, come fosse temuta, uno spauracchio, mentre dovrebbe essere un evento all’interno del percorso della vita. L’uomo, però, spesso muore da solo, pur avendo tante persone intorno a sé».
Prima di entrare nel vivo dei lavori un saluto è arrivato anche da Giovanni Poles, da poco nominato responsabile regionale della Rete Cure Palliative. «La prima cosa che dobbiamo fare – ha sottolineato – è testimoniare quello che vediamo ogni giorno in queste realtà: le cure palliative sono forse proprio la risposta alla domanda che dà il titolo al convegno. Non si muore soli se c’è una rete di relazioni e di persone che rispondono ai bisogni del malato, non solo in termini di competenza tecnica, ma anche di dimensione umana. Le soluzioni estreme, spesso, sono la conseguenza logica di qualcosa che manca. Quando non si può più guarire, si può ancora curare».
Riflessioni ad ampio spettro
Ritagliarsi uno spazio in un tempo che scorre perché quando si ha a che fare con la morte ci viene chiesto di fermarci. È con queste parole che Laura Dal Corso ha dato il via alla prima sessione dei lavori con Ornella Mancin, presidente della Fondazione Ars Medica, che ha aggiunto: «La morte non è un argomento facile perché suscita in tutti noi paure e angosce. La morte è un pensiero che viene rimosso dalla nostra dimensione personale e pubblica. Spesso si pensa che il malato terminale non abbia più alcun diritto di esprimere la propria opinione e invece bisogna aiutare a morire con dignità attraverso percorsi condivisi».
Parte, dunque, da qui la necessità di un convegno di questo tipo che ha affrontato durante la prima parte della mattinata tre temi importanti: la dimensione spirituale della morte come porta verso l’ignoto, verso il mistero; la riflessione sul morire soli o morire in solitudine; il passaggio dalla congiura del silenzio a un silenzio empatico.
«Di fronte alla morte – ha spiegato padre Guidalberto Bormolini, monaco e sacerdote dei “Ricostruttori nella preghiera” – bisogna trovare altre vie. L’ignoto è un terreno fondamentale nell’avvicinarsi alla morte perché ci orienta all’infinito, ci apre la prospettiva al mistero. La morte lascia aperte tutte le possibilità».
Per cogliere queste possibilità, però, bisogna spostare lo sguardo, ribaltare la visione che ognuno ha della morte intendendola come compimento della vita, non come la sua cessazione, come un aspetto, un passaggio non come la fine di tutto. «La nostra morte – ha concluso – può essere un dono agli altri perché è piena di senso. Sono le nostre nozze col mistero e con l’eternità».
A Cosimo De Chirico, medico palliativista già coordinatore regionale SICP, invece, il compito di raccontare i pilastri dell’accompagnamento alla morte, anche attraverso le significative immagini di un paziente in coma che assiste, però, alla prima comunione del figlio. «Oggi la morte – ha sottolineato – è un tabù. Serve una nuova domanda di etica».
Di fronte al fine vita sono due le strategie possibili: pensare che quella persona non abbia più nulla da dare, pensarla solo come un corpo che sta morendo o pensare, invece, che quel malato continua a essere comunque una persona. «In questo caso – ha aggiunto – la persona si prende in carico, si valutano i suoi bisogni, si cerca di far esprimere al paziente le proprie emozioni», come si fa con le cure palliative.
Tra i pilastri, dunque dell’accompagnamento:
- il pensarci prima, quando ci sono i sintomi, quando c’è una diagnosi, quando non è troppo tardi;
- l’alleviare la sofferenza fisica perché se la persona soffre non può relazionarsi con nessuno;
- la comprensione dei bisogni;
- le cure proporzionate;
- il decodificare la richiesta del paziente di essere aiutato a morire: spesso la morte viene vissuta come l’ultima possibilità di recuperare dignità, non è quasi mai una richiesta eutanasica, ma una richiesta d’aiuto che si supera attraverso la relazione.
«Quando si muore, allora – le conclusioni di De Chirico – si muore certamente soli, ma non si deve morire in solitudine».
Sul silenzio e i suoi molteplici aspetti, infine, l’approfondimento arrivato da Ines Testoni, docente associato di Psicologia sociale e direttore del Master in Death Studies dell’Università di Padova. «Quando si muore – ha spiegato – si muore necessariamente soli, anche se si è in compagnia. E non è detto si muoia meglio. La solitudine è una grande conquista».
Peccato, però, che l’uomo non sia capace di stare solo e in silenzio, in una sorta di afasia relazionale che lo fa parlare molto, ma spesso a vanvera. «Intorno alla morte, invece – ha aggiunto – si fa molto rumore. Parliamo tanto in modo assordante perché abbiamo paura di ascoltare ciò che ha da dire chi sta per morire».
La congiura del silenzio, allora, è il non ascoltare che, però, comunica comunque qualcosa: l’idea che l’altro non abbia più alcun diritto di esprimere alcunché di sé in profondità. Questo silenzio che parte da presupposti sbagliati deve essere, invece, sostituito dal silenzio empatico, dalla consapevolezza «di non saper parlare, dalla capacità di entrare in se stessi in profondità e di saper tacere».
I testimoni
Dopo le riflessioni ad ampio spettro, la seconda parte della mattinata è stata dedicata alle testimonianze dirette di chi con la morte ha a che fare tutti i giorni. Introdotti da Emanuela Blundetto, medico di famiglia e consigliere dell’OMCeO veneziano, e da Marisa Galbussera, consigliere dell’Ordine degli Psicologi, si sono alternati sul palco a raccontare le loro esperienze medici palliativisti, direttori di strutture residenziali, psicologi e psicoterapeuti, volontari, tra cui Gloria Baracco, dirigente del Nucleo di Cure Palliative dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, il responsabile delle Cure Palliative dell’Ulss 4 Veneto Orientale Luciano Lamarca, Teresa Baldi Guarinoni ed Eleonora Cason, presidente la prima e psicologa la seconda dell’associazione Avapo, Elisa Mencacci, presidente di Amcn onlus e Paolo Giacobello, responsabile socio sanitario della Residenza per anziani e Hospice di Portogruaro dell’Ulss 4.
Tra le testimonianze più significative la toccante storia di Aldo, pensionato 75enne, ex operaio Montedison, malato senza possibilità di guarigione, proposta da Roberto Zanibellato, medico di famiglia veneziano e membro del comitato scientifico della Fondazione Ars Medica.
Un intervento per raccontare non solo le proprie difficoltà – «ogni volta – dice – che mi trovo davanti a una prognosi infausta, ho la sensazione di perdere la partita, di essere sconfitto» – i propri ostacoli, il proprio approccio con la morte, ma anche quelle del paziente e dei suoi familiari nell’accettare una malattia senza speranza, la loro delusione, i loro dubbi, la loro disperazione, la loro volontà di trovare una via d’uscita.
Sentimenti di paura, di smarrimento e di ansia che non provano solo il paziente e i familiari, ma anche i professionisti che lo seguono nel suo percorso verso la morte. Angosce che si abbattono avvicinandosi di più al paziente, entrando in confidenza con lui, prendendosi cura di lui, ascoltandolo.
Prendersi cura non solo di chi muore, ma anche di chi rimane, il monito lanciato dall’infermiere Claudio Ferro – il figlio dice di lui: «Il mio papà fa il lavoro più bello del mondo: aiuta le persone a morire» – che esorta a saper accompagnare, saper ascoltare, a passare dall’essere all’esserci perché nei malati terminali «se guardo la malattia non c’è più niente da fare, ma se guardo la persona c’è ancora moltissimo da fare».
Tra gli altri temi affrontati nei numerosi interventi: l’importanza di lavorare in équipe e di saper comunicare; la necessità di avere ruoli chiari e distinti, seppur integrati, nell’accompagnamento alla morte, ma anche di avere chiari i bisogni di base per dare risposte specifiche e ben integrate; il bisogno di diffondere le cure palliative anche in ambiti non oncologici e la necessità nelle strutture socio sanitarie, dove si gestiscono circa 100 decessi all’anno, di generare con gli ospiti legami significativi.
Un pomeriggio tra teatro e musica
Tracciati i contorni del contesto, la sessione pomeridiana del convegno, introdotta da Gina Barbano e Gabriele Gasparini, consiglieri rispettivamente dell’Ordine degli Psicologi e dell’OMCeO veneziano, ha perso le proprie caratteristiche tipiche di lezione frontale per declinarsi nelle forme del teatro forum e della musica. Nel nel primo caso con l’idea di provocare il dibattito, nel secondo – grazie ai canti degli Armonici Ricostruttori e alle letture di Elisabetta Salvatori – per avvicinarsi alla meditazione e a quella dimensione spirituale necessaria in questo percorso.
Il caso di un paziente terminale, della comunicazione talvolta fallimentare con lui e con i suoi figli da parte di un medico, di una psicologa e di un infermiere, è stato portato in scena da un gruppo di medici e psicologi – Oscari Miotti, Alvise Patron Zennaro, Antonella Romeo, Federico Pavanello, Matteo Zampieri e Beatrice Priori – animato da Marco Ballico, medico, psicoterapeuta e docente IUSVE, e poi discusso con il pubblico.
«Il nostro percorso di studi – una delle riflessioni – è tecnico, non ci prepara ad essere buoni comunicatori. La scena spiega bene la nostra difficoltà quotidiana. Io all’inizio scappavo via. Ora non sono abile e capace, ma la mia sensibilità si è un po’ affinata». «In scena – un altro commento – ho visto un medico che non aveva il coraggio di guardare in faccia la realtà».
Ciò che serve, invece, nel percorso di accompagnamento alla morte è proprio questo coraggio di affrontare la realtà, il coraggio di prendersi cura: in sinergia con i colleghi, con professionalità, ma anche umanità, con empatia e capacità di ascolto, ma anche di silenzio. Non è un percorso facile – è stato ripetuto più volte – la morte è ancora un tabù, ma è l’unica strada per non far morire qualcuno in solitudine pur dovendo necessariamente morire solo.
Chiara Semenzato, giornalista OMCeO Provincia di Venezia
Segreteria OMCeO Ve
Categoria News:
Notizie medici
Pagina visitata 4645 volte