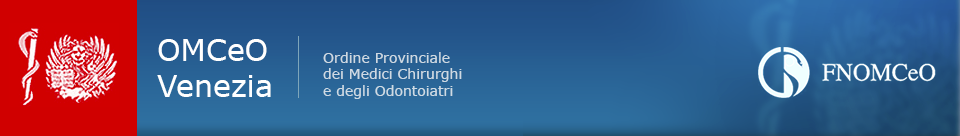- Home
- News
- Odontoiatri
Hikikomori: un fenomeno da scoprire, capire, affrontare
Data di inserimento: Martedì, 24/04/18 - Segreteria OMCeO Ve

La loro è una scelta consapevole: le troppe pressioni, le troppe aspettative, la competizione sfrenata di questo mondo li spingono a isolarsi, a rifiutare i dogmi sociali, a “stare in disparte” come dice la traduzione letterale del termine giapponese che li identifica. Sono gli hikikomori, ragazzi tra i 14 e i 25 anni, che ad un certo punto della loro giovane esistenza, spesso quando approdano alle superiori, decidono di vivere in solitudine, chiusi nella loro camera da letto. Pur essendo molto intelligenti e sensibili e spesso molto più maturi della loro età, non si sentono all’altezza di questo mondo e dei loro coetanei, si sentono diversi e se ne vergognano: così si ritirano, disinteressati a qualsiasi tipo di relazione.
Il fenomeno, che è nato ed esploso in Giappone negli anni ‘80 e tende a rimanere invisibile al mondo esterno, è stato presentato venerdì 20 aprile al Centro Cardinal Urbani di Zelarino in un partecipatissimo seminario organizzato – sulla spinta della psicologa e psicoterapeuta Giovanna Borsetto e di Giulia Rossetto – da Hikikomori Italia, con i patrocini del Comune di Venezia, dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e dell’OMCeO lagunare.
«Quando poco tempo fa mi è stata pronunciata questa parola – ha spiegato il segretario Luca Barbacane portando i saluti del presidente Giovanni Leoni e del direttivo dell’Ordine – anch’io ho spalancato gli occhi. Non ne sapevo proprio nulla: questa per me è anche un’occasione di formazione personale. Con il ritiro sociale giovanile i medici centrano non tanto perché ne sappiano, ma perché ci tengono a fare rete, a essere uno dei nodi di questa rete. Questa è una sensibilità da seminare e da costruire anche nella comunità medica, ma i medici vogliono giocare questa partita. Rimaniamo a disposizione di Hikikomori perché siamo convinti che la conoscenza anche attraverso i medici e i pediatri sia importante per essere d’aiuto e per sapere a chi indirizzare questi giovani».
 Un fenomeno, dunque, pressoché sconosciuto anche se in Italia le stime – un’analisi precisa non è ancora stata condotta – dicono che gli hihikomori sono 100mila. Migliaia di ragazzi isolati, chiusi nelle loro camere, e migliaia di genitori che piombano all’improvviso in un incubo, che non sanno come affrontare, che si sentono abbandonati e, talvolta, addirittura vessati dalle istituzioni.
Un fenomeno, dunque, pressoché sconosciuto anche se in Italia le stime – un’analisi precisa non è ancora stata condotta – dicono che gli hihikomori sono 100mila. Migliaia di ragazzi isolati, chiusi nelle loro camere, e migliaia di genitori che piombano all’improvviso in un incubo, che non sanno come affrontare, che si sentono abbandonati e, talvolta, addirittura vessati dalle istituzioni.
Ad occuparsi di loro, sensibilizzando sul problema, promuovendo iniziative e creando una rete per condividere esperienze, due associazioni: Hikikomori Italia, fondata nel 2017 da Marco Crepaldi – che ha conosciuto per caso il termine grazie a un anime giapponese e ha deciso poi di farne l’argomento della sua tesi di laurea – ma attiva con un blog fin dal 2013; e la parallela Hikikomori Genitori Onlus, guidata da Elena Carolei, con molti gruppi già attivi in tante città d’Italia.
«Quando ho conosciuto questo fenomeno – ha spiegato Crepaldi all’inizio dell’incontro – ho capito che non era limitato solo al Giappone. Vogliamo iniziare a parlarne, creare dibattito perché questi genitori devono essere aiutati: sono più soli dei ragazzi stessi. L’obiettivo di questo seminario, allora, è creare un circolo virtuoso che porti tutti, scuole, comuni, istituzioni sanitarie, associazioni, ad interessarsi al problema. Un approccio multidisciplinare per dotarsi di quegli strumenti indispensabili a comprendere il fenomeno e ad affrontarlo con efficacia».
Grazie all’esperienza maturata dall’associazione, si può tracciare un profilo dell’hikikomori: è per lo più maschio (le ragazze sono il 30%), adolescente o giovane adulto, figlio unico, spesso di famiglia monoparentale, introverso, intelligente e sensibile, critico e negativo nei confronti della società.
«Si isola – ha spiegato Crepaldi – perché sente troppo forti le pressioni di realizzazione sociale: c’è troppa competitività su tutti i livelli, esasperata poi anche dai social media e da facebook. Ci si vergogna di non avere una vita all’altezza dei propri coetanei. Le pressioni possono venire da qualsiasi parte: dalla moda, dalla tv, dai genitori, dagli amici. L’hikikomori, allora, rifiuta i dogmi sociali, rinuncia alla vita sociale classica».
Tre gli stadi del processo: si comincia con il rifiuto saltuario di andare a scuola, l’inversione del ritmo sonno-sveglia e la preferenza alle relazioni virtuali; si passa, poi, all’abbandono di tutti i contatti sociali, tranne i genitori e le relazioni virtuali, per finire con l’isolamento totale, reale e virtuale.
Attenzione, però, perché l’hikikomori non è un ragazzo depresso, semmai lo sviluppo di psicopatologie è conseguenza dell’isolamento. «Vive – ha sottolineato il fondatore dell’associazione – una sorta di depressione esistenziale. Questi ragazzi non sono clinicamente depressi e non sono dipendenti da internet. Stando tutto il giorno in camera, ne abusano ma per loro è solo un mezzo di intrattenimento e di comunicazione con il mondo esterno. Infine non è fobia sociale: non c’è solo paura, di essere giudicati o di esporsi socialmente, c’è una componente fortemente interiorizzata di negatività verso le relazioni che spinge il ragazzo a rimanere rinchiuso. È una scelta che lui fa consapevolmente: il ragazzo hikikomori non vuole essere aiutato perché ti dice che lui sta bene».
Una condizione che provoca grandi sofferenze alle famiglie, come ha ben raccontato durante la serata Elena Carolei. «Viviamo – ha detto – in un paradosso che non riusciamo a capire. Vediamo i nostri figli, bravi, intelligenti, brillanti, capaci a scuola e nelle altre attività, di cui siamo orgogliosi e di cui già assaporiamo un futuro glorioso, chiudersi all’improvviso, diventare aggressivi e prepotenti, rifiutare qualsiasi tipo di aiuto, abbandonare gli studi, magari essere anche bocciati».
Si procede, allora, un po’ per tentativi, spesso anche facendo errori clamorosi. «Noi genitori – ha aggiunto – siamo molto soli nel fronteggiare questo problema. Ci siamo riuniti in un’associazione proprio perché abbiamo bisogno del confronto e di condividere le esperienze. Col tempo abbiamo capito che l’unico modo per aiutare i nostri ragazzi è ribaltare le nostre certezze, uscire da esse, comprendendo il loro disagio, entrando nel loro modo di vedere il mondo, cercando di aiutarli dal loro punto di vista con pazienza e comprensione, senza fare pressioni. Solo così, pian piano, i ragazzi si sentono capiti in famiglia e qualcosa iniziano a fare, a riprovare».
L’asticella, insomma, non va alzata, ma abbassata. «Chi è che, dopo aver messo una mano sul fuoco – ha scritto un ventenne ai genitori del gruppo – ed essersi ustionato gravemente, farebbe la stessa cosa immediatamente dopo? Eppure a noi viene chiesto di farlo».
Il lavoro, però, non deve piombare tutto e solo sulle spalle delle famiglie. Contro il ritiro sociale giovanile è indispensabile fare rete. «Noi abbiamo capito cosa fare – ha sottolineato Carolei – ora chiediamo la consapevolezza delle istituzioni, chiediamo aiuto, di documentarsi, di iniziare a riconoscerli in classe, di ascoltare le famiglie, di evitare mansioni che puntino l’attenzione su questi ragazzi, di cercare soluzioni, attivare forme di risocializzazione protetta».
Questo nell’immediato, ma per il futuro sono altre le richieste di questi genitori: vogliono che il fenomeno sociale sia classificato, abbia una propria dignità, che si possano fare interventi a domicilio, perché solo così si possono raggiungere persone che non vogliono essere raggiunte, che ci siano forme di supporto individuale. E poi chiedono di non essere sanzionate, come le ingiunzioni che arrivano dal tribunale per l’abbandono scolastico: perché loro, le famiglie, non sono complici, più di ogni altra cosa vorrebbero per i loro figli una vita sociale normale.
Della necessità della rete, anche sotto il profilo clinico, ha parlato nel suo intervento il neurologo e neuropsichiatra Lodovico Perulli. «Ci sono problematiche – ha spiegato – che noi apparentemente consideriamo psichiatriche, ma che in realtà hanno ben poco a che fare con la psichiatria. L’approccio multidisciplinare è fondamentale nella nostra pratica clinica, se si pensa a patologie gravi come, ad esempio, i disturbi alimentari o i suicidi adolescienziali. Per poterle affrontare ci deve essere un consenso e un concorso di più saperi che devono confrontarsi tra loro in maniera collaborativa e trovare soluzioni operative».
Il medico ha poi spiegato come rispetto al fenomeno hikikomori la letteratura scientifica sia ancora all’inizio, come non ci sia consenso sui criteri diagnostici, come alcuni studi sostengano il legame con le psicopatologie, come il termine sia ancora controverso, come non sia ancora chiaro di cosa si stia parlando.
Perulli ha, però, anche raccontato la propria esperienza personale a riguardo, alcuni casi che hanno attraversato il suo percorso professionale. «Alcuni – ha detto – li ho conosciuti solo indirettamente, attraverso i racconti dei genitori. Mi è capitato, però, un ragazzo che da 2 anni non usciva più di casa, dopo un’esperienza traumatica, la morte del padre sotto i suoi occhi. Questo ragazzo non aveva una depressione clinica, aveva deciso volontariamente di restare chiuso in casa. Lo hanno portato in comunità dove è rimasto un anno: quando è uscito, mi ha detto “questo è stato l’anno più bello della mia vita”. Noi psichiatri dobbiamo cercare di essere in questi casi molto prudenti, di essere aperti alla valutazione quando riusciamo a conoscere i ragazzi».
Altra importante decisione presa dal dottor Perulli, considerato che gli hikikomori non si muovono da casa, quella di creare a Padova un’équipe mobile per andare a domicilio. «Il contributo dello psichiatra – ha aggiunto – può essere quello di realizzare diagnosi differenziate, di contribuire a definire il profilo psicologico ed emotivo di un adolescente e di escludere eventuali psicopatologie. Si è visto, infatti, che anche se noi curiamo l’ansia o la depressione o il sintomo ossessivo, non curiamo la persona nella sua decisione di ritirarsi e resta isolata».
Restare isolati, per questi ragazzi, significa rinunciare non solo alla scuola, ma anche all’amicizia, alla scoperta, agli approcci amorosi, ai viaggi, al gruppo, perfino alla trasgressione. In qualche modo rinunciare alla vita. «Per questi ragazzi – ha concluso il neuropsichiatra – la vergogna è un sentimento potente».
Individuare, allora, i loro bisogni specifici, rimodulare, ad esempio, l’impegno scolastico, in modo flessibile, sulle loro esigenze, facendo in modo che non si sentano esclusi dalla scuola, supportare i genitori, promuovere interventi domiciliari sono solo le prime tappe di un percorso che, però, può rivelarsi virtuoso. Ecco, allora, perché servono la consapevolezza e la collaborazione di tutti: una rete che accolga e protegga l’hikikomori, per spingerlo a non essere più uno che vuole “stare in disparte”.
Chiara Semenzato, giornalista OMCeO Provincia di Venezia
Segreteria OMCeO Ve
Categoria News:
Notizie medici
Pagina visitata 7034 volte